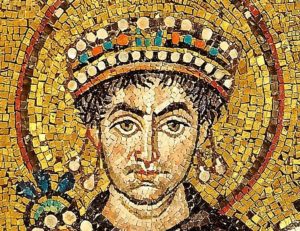PIER DELLA VIGNA E IL SUICIDIO IN CARCERE – “INGIUSTO FECE ME CONTRA ME GIUSTO”


DANTE E PILLOLE DI DIRITTO ATTUALE
“L’opera e il pensiero di Dante poggiano chiaramente su una impalcatura di matrice legale. La centralità del diritto si avverte soprattutto nella Commedia: Dante immagina l’aldilà come una struttura amministrativa fortemente regolata, dotata di una complessa rete di leggi locali, giurididizioni gerarchiche, punizioni e ricompense ben calcolate” (Justin Steinberg, Dante e i confini del diritto).
Qui però si vuole solo un’occasione, nell’anniversario dei 700 anni dalla mortre del Poeta, per (ri)leggere qualche passo del capolavoro, anch’esso bene comune, italiano e dell’umanità.
E, solo secondariamente, aggiungere qualche spunto di riflessione: giusto affinchè, per il piacere della lettura di tale opera, non si resti troppo distaccati dalla realtà.
PIER DELLA VIGNA E IL SUICIDIO IN CARCERE – “INGIUSTO FECE ME CONTRA ME GIUSTO”

Inferno, Canto XIII, 64-72
La meretrice che mai da l’ospizio
di Cesare non torse li occhi putti,
morte comune e de le corti vizio,
infiammò contra me li animi tutti;
e li ’nfiammati infiammar sì Augusto,
che ’ lieti onor tornaro in tristi lutti.
L’animo mio, per disdegnoso gusto,
credendo col morir fuggir disdegno,
ingiusto fece me contra me giusto.
Dove ci troviamo
All’interno dell’opera, ossia la Comedìa, comunemente più conosciuta come Divina Commedia, ci troviamo nella Cantica dell’Inferno, al Canto XIII, ricco, stilisticamente, di raffinatezze poetiche: anafore (non fronda verde, ma di color fosco; non rami schietti, ma nodosi e ‘nvolti; non pomi v’eran, ma stecchi con tòsco, per rafforzare l’immagine del bosco spettrale, con fogliame scuro e ramaglie contorte, e spine velenose anzichè frutti), allitterazioni (similemente a colui che venire sente ‘l porco e la caccia a la sua posta, ch’ode le bestie, e le frasche stormire, per riprodurre il rumore dei movimenti nella boscaglia, come nella battuta al cinghiale con i cani), allitterazioni con chiasmi (ingiusto fece me contra me giusto), allitterazioni con poliptoti (cred’io ch’ei credette ch’io credesse; infiammò contra me li animi tutti; e li ‘nfiammati infiammar sì Augusto), allitterazioni con antitesi (per disdegnoso gusto, credendo col morir fuggir disdegno) etc etc.
Ma il Canto XIII dell’Inferno, oltre che piacevole per gli artifizi di stile, è interessante anche per i personaggi che Dante menziona, e in particolare per l’incontro con Pier della Vigna: dottissimo letterato e funzionario alla corte di Federico II di Svevia, a cui il Poeta dà modo di parzialmente riabilitarsi, rispetto alla cattiva fama di corrotto e di traditore che lo contraddistingueva nelle cronache del tempo.
All’interno dell’inferno, ci troviamo nel VII Cerchio, dove sono puniti i violenti, in tre gironi distinti, ciascuno dei quali ospita una categoria particolare di loro:
- nel primo girone (a cui era dedicato il precedente XII Canto), un fiume rosso di sangue bollente (il Flegetonte, riviera del sangue in la qual bolle), si trovano i violenti contro il prossimo, ossia i tiranni, gli assassini, i predoni e i ladruncoli: sono costretti a restarvi immersi (alcuni fino agli occhi, altri fino al collo, altri fino al petto, altri fino ai piedi) dalla vigilanza dei centauri che fanno ronda sulle due rive (esseri mostruosi metà umani e metà cavalli, che in traccia corrien, armati di saette);
- nel secondo girone (a cui è dedicato appunto il XIII Canto), una boscaglia selvaggia, si trovano i violenti contro se stessi: nella persona, ossia i suicidi, e nel patrimonio, ossia gli scialacquatori; i primi, i suicidi, sono stati trasformati in piante e, imprigionati in esse, vengono straziati dalle arpie (esseri mostruosi metà umani e metà uccelli: ali hanno late, e colli e visi umani, piè con artigli, e pennuto ’l gran ventre, e fanno lamenti) che nidificano tra i rami e si cibano delle foglie; i secondi, gli scialaquatori, corrono invece tra le piante, venendo inseguiti da belve (nere cagne, bramose e correnti) che, quando li raggiungono, li fanno a brandelli;
- nel terzo girone (a cui sarà dedicato il successivo XIV Canto), un terreno sabbioso reso infuocato da una pioggia di fiamme (l’orrido sabbion: una rena arida e spessa, ove piovean di foco dilatate falde), si trovano i violenti contro Dio: nella persona divina, ossia i bestemmiatori; nella natura umana, ossia i sodomiti, nell’operosità umana, ossia gli usurai; i primi, i bestemmiatori, devono restare sdraiati supini nella sabbia rovente; i secondi, i sodomiti, devono camminarvi senza posa, i terzi, gli usurai, devono restarvi seduti portando al collo una borsa con lo stemma della loro famiglia.
Ora Dante e Virgilio sono stati trasportati oltre il fiume Flegetonte dal centauro Nesso, e si stanno addentrando in una selva spettrale (un bosco che da neun sentiero era segnato) ove, come il Poeta scoprirà, sono costretti coloro che si suicidarono, tramutati in alberi ed esposti a soffererenze: spezzando un ramo (colsi un ramicel da un gran pruno) vede sgorgare liquido e sente una voce parlare (usciva insieme parole e sangue), lamentandosi (’l tronco suo gridò: perché mi schiante? … perché mi scerpi? non hai tu spirto di pietade alcuno?) e raccontando la sua sorte (uomini fummo, e or siam fatti sterpi).
E’ un topos: la scena richiama un episodio raccontato da Virgilio nell’Eneide (di quando Enea strappando delle fronde per metterle su un altare sente la voce di Polidoro, figlio di Priamo, re di Troia, fatto uccidere dagli invasori per impossessarsi del tesoro della città) e sarà richiamata da Torquato Tasso nella Gerusalemme Liberata (di quando Tancredi colpendo un cipresso con la spada, per sfogarsi, sente la voce di Clorinda, guerriera saracena da lui uccisa in duello).
Il dannato trasformato in albero che colloquia con Dante è Pier Della Vigna, uomo di lettere ma anche di legge, consigliere fidatissimo dell’imperatore Federico, caduto in disgrazia per l’invidia altrui, a suo dire, e suicidatosi in carcere per le sofferenze e il disonore di una condanna e di una pena che riteneva ingiuste.
Io son colui che tenni ambo le chiavi del cor di Federigo, e che le volsi, serrando e diserrando, sì soavi, che dal secreto suo quasi ogn’uom tolsi: fede portai al glorioso offizio, tanto ch’i’ ne perde’ li sonni e ’ polsi. La meretrice che mai da l’ospizio di Cesare non torse li occhi putti, morte comune e de le corti vizio, infiammò contra me li animi tutti; e li ’nfiammati infiammar sì Augusto, che ’ lieti onor tornaro in tristi lutti. L’animo mio, per disdegnoso gusto, credendo col morir fuggir disdegno, ingiusto fece me contra me giusto. Per le nove radici d’esto legno vi giuro che già mai non ruppi fede al mio segnor, che fu d’onor sì degno. E se di voi alcun nel mondo riede, conforti la memoria mia, che giace ancor del colpo che ’nvidia le diede.
Io sono colui che di Federico II di Svevia tenne entrambe le chiavi del cuore (il volere e il non volere), e che le usai così dolcemente, chiudendo ed aprendo, che esclusi dai suoi segreti quasi tutti (divenni cioè il suo più fidato consigliere): fui fedele al mio prestigioso incarico, al punto che persi per questo il sonno e la salute. La prostituta (l'invidia) che non distolse mai i suoi occhi disonesti dalla reggia dell'imperatore, e che è rovina comune degli uomini e vizio speciale delle corti, infiammò contro di me gli animi di tutti; ed essi da infiammati infiammarono a loro volta l'imperatore, al punto che i miei lieti onori si trasformarono in tristi lutti. Il mio animo, per gusto di disprezzo, credendo di sfuggire il disonore con la morte, mi rese ingiusto contro me stesso, che pure non avevo colpe. Per le nuove radici di questo albero, vi giuro che non fui mai infedele al mio signore, che fu tanto degno di onore. E se qualcuno di voi tornerà nel mondo terreno, riabiliti la mia memoria, che ancora giace per il colpo l'invidia gli diede.
Chi era Pier della Vigna
Pier della Vigna nacque a Capua, attorno a 1190, e morì a Pisa, nel 1249: certamente tra le personalità più dotte del suo tempo, letterato e funzionario di altissimo livello alla corte di Federico II di Svevia (l’Hohenstaufen, nipote di Federico Barbarossa che fu Re di Sicilia, e poi Imperatore del Sacro Romano Impero, passato alla storia addiruttura con l’appellativo di Stupor Mundi, per il segno lasciato), è difficile descrivere la sua “professione” con temini moderni.
Nato in una famiglia di rango (il padre era magister, una sorta di giudice) ma in ristrettezze economiche (tando da dover mendicare per potersi pagare gli studi), frequentò lo Studium di Bologna, ossia la scuola giuridica precorritrice della più antica università del mondo, e fu allievo del maestro Bene.
Alla Corte di Federico entrò in servizio come tabellione, una sorta di notaio: fece poi parte della ristretta cerchia dei dictatores, ossia di coloro che redigevano i documenti imperiali, soprattutto lettere e circolari, e fu molto attivo anche nella vita culturale, tenendo rapporti con poeti, scienziati, filosofi e teologi (di lui è rimasto un Epistolario, raccolta di svariati documenti e formulari, che per secoli fu preso a modello in corti e cancellerie).
Fu giudice e diplomatico: nella prima veste, ricoprì le cariche di logoteta e protonotario (una sorta di cancelliere del sovrano, superiore ai notai e custode dei sigilli), e di gran giudice della corte imperiale (in tale veste presidette alla relizzazione della c.d. Costituzione di Melfi: un codice legilativo molto all’avanguarda, naturalmente per l’epoca); nella seconda veste, fu ambasciatore e svolse missioni molto delicate, a Roma (presso il Papato, che si contrapponeva fortemente con l’Imperatore Federico) e a Londra (il maggior successo furono le nozze, da lui registrate come procuratore, tra l’Imperatore Federico e Isabella, sorella del re d’Inghilterra, che per ringraziarlo lo nominò vassallo e gli assegnò una rendita).
Accumulò ricchezze, e attirò invidie: cos’è, e cosa non è, fu arrestato come traditore, a seguito di una congiura e/o con l’accusa di corruzione: l’imperatore Federico, in una lettera, scrisse che Pier delle Vigne, che era stato il suo collaboratore più fidato, aveva “trasformato il bastone della giustizia in un serpente” (avrebbe addirittura fatto condannare innocenti per poterne confiscare i beni), recando pericolo e danno all’impero.
Fu arrestato a Cremona e fu trasportato a Pontremoli, nella cui piazza fu fatto accecare a mezzo di un ferro ardente, per ordine dell’Imperatore: fu quindi portato in prigione in quel di Pisa.
Incarcerato si suicidò, sbattendo volontariamente la testa contro la parete della cella.
Per Dante, era un uomo giusto che, a causa di una ingiustizia (una accusa infondata, e una pena disumana, con l’accecamento e la prigionia), fece su di sè un’altra ingiustizia (il suicidio è peccato, perchè l’uomo non è padrone della sua vita, che ha ricevuto da Dio e che deve comunque rispettare, anche a servizio della collettività).
Insomma: un suicidio in carcere.
Cose d’altri tempi ?
Ogni anno nelle carceri italiane si registrano, secondo le statistiche dal 2000 ad oggi, tra i 120 e i 180 decessi: circa un terzo sono i suicidi.
Nel 2019 erano stati 53, nel 2020 sono stati 61, con un notevole aumento (nonostante la popolazione carceria sia, invero, diminuita, per la prima volta da molti anni: al 31.12.20 i detenuti erano circa 53.000, rispetto ai circa 61.000 al 31.12.19).
Un dramma, che coinvolge persino il personale della polizia penitenziaria (una decina di casi all’anno, pare), come rivelato dal Garante dei detenuti.
Il sovraffollamento è sicuramente una concausa: in proporzione, per avere un’idea, dove dovrebbero stare 100 denuti se ne fanno stare invece 120, ma la situazione non è omogenea (attualmente al Regina Coeli di Roma sono ospitate 900 persone rispetto a 606 posti di capienza regolamentare, a al Nerio Fischione d Brescia 338 rispetto a 186, al Rocco D’Amato di Bologna 688 su 500, alla Casa Circondariale di Busto Arsizio 358 rispetto a 240).
Piccola riflessione finale
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha ripetutamente condannato lo Stato Italiano per la situazione delle carceri: alla famosa sentenza “Torregiani” del 2013, che ravvisò condizioni di reclusione definite “inumane e degradanti” (i ricorrenti, che ottenero un risarcimento, erano sette persone detenute per molti mesi nelle carceri di Busto Arsizio e di Piacenza, in celle triple e con meno di quattro metri quadrati a testa a disposizione) ne sono seguite molte: l’Avvocatura della Camera dei Deputati (esiste pure quella) nè dà conto ogni anno, nei quaderni del suo importante Osservatorio.
Il problema del sovraffollamento delle strutture penitenziarie, di cui è manifestazione estrema il fenomeno del suicidio in carcere, è questione annosa, conclamata, ma irrisolta, pur nella piena consapevolezza anche del Governo e del Parlamento, come detto.
E ciò nonostante si spenda non poco: i calcoli sono opinabili (la stima di Euro 137/giorno/denuto, che si trova in pubblicazioni del Sindacato Autonomo della Polizia Penitenziaria, è solo indicativa, derivando, anche semplicisticamente, dalla divisione della spesa complessiva indicata dal Ministero della Giustiza anche a fini statistici europei, ossia Euro 3.000.000 circa/anno per il numero di detenuti e per il numero di giorni), ma le cifre sono comunque significative e in linea con le medie europee.
Eppure, secondo le “classifiche” del Consiglio d’Europa, a risultati, a livello cioè di decenza e umanità delle strutture carcerarie, siamo tra i peggiori d’Europa (seguiti solo da Macedonia del Nord, Romania e, toh, Francia).
Pare ovvio che i soldi pubblici, dei contribuenti, siano spesi male, molto male: anche per i detenuti.
* * *
Il testo completo del Canto XIII dell’Inferno:
Non era ancor di là Nesso arrivato, quando noi ci mettemmo per un bosco che da neun sentiero era segnato. Non fronda verde, ma di color fosco; non rami schietti, ma nodosi e 'nvolti; non pomi v'eran, ma stecchi con tòsco. Non han sì aspri sterpi né sì folti quelle fiere selvagge che 'n odio hanno tra Cecina e Corneto i luoghi cólti. Quivi le brutte Arpie lor nidi fanno, che cacciar de le Strofade i Troiani con tristo annunzio di futuro danno. Ali hanno late, e colli e visi umani, piè con artigli, e pennuto 'l gran ventre; fanno lamenti in su li alberi strani. E 'l buon maestro «Prima che più entre, sappi che se' nel secondo girone», mi cominciò a dire, «e sarai mentre che tu verrai ne l'orribil sabbione. Però riguarda ben; sì vederai cose che torrien fede al mio sermone». Io sentia d'ogne parte trarre guai e non vedea persona che 'l facesse; per ch'io tutto smarrito m'arrestai. Cred' ïo ch'ei credette ch'io credesse che tante voci uscisser, tra quei bronchi, da gente che per noi si nascondesse. Però disse 'l maestro: «Se tu tronchi qualche fraschetta d'una d'este piante, li pensier c'hai si faran tutti monchi». Allor porsi la mano un poco avante e colsi un ramicel da un gran pruno; e 'l tronco suo gridò: «Perché mi schiante?». Da che fatto fu poi di sangue bruno, ricominciò a dir: «Perché mi scerpi? non hai tu spirto di pietade alcuno? Uomini fummo, e or siam fatti sterpi: ben dovrebb' esser la tua man più pia, se state fossimo anime di serpi». Come d'un stizzo verde ch'arso sia da l'un de' capi, che da l'altro geme e cigola per vento che va via, sì de la scheggia rotta usciva insieme parole e sangue; ond' io lasciai la cima cadere, e stetti come l'uom che teme. «S'elli avesse potuto creder prima», rispuose 'l savio mio, «anima lesa, ciò c'ha veduto pur con la mia rima, non averebbe in te la man distesa; ma la cosa incredibile mi fece indurlo ad ovra ch'a me stesso pesa. Ma dilli chi tu fosti, sì che 'n vece d'alcun' ammenda tua fama rinfreschi nel mondo sù, dove tornar li lece». E 'l tronco: «Sì col dolce dir m'adeschi, ch'i' non posso tacere; e voi non gravi perch' ïo un poco a ragionar m'inveschi, Io son colui che tenni ambo le chiavi del cor di Federigo, e che le volsi, serrando e diserrando, sì soavi, che dal secreto suo quasi ogn' uom tolsi; fede portai al glorïoso offizio, tanto ch'i' ne perde' li sonni e ' polsi. La meretrice che mai da l'ospizio di Cesare non torse li occhi putti, morte comune e de le corti vizio, infiammò contra me li animi tutti; e li 'nfiammati infiammar sì Augusto, che ' lieti onor tornaro in tristi lutti. L'animo mio, per disdegnoso gusto, credendo col morir fuggir disdegno, ingiusto fece me contra me giusto. Per le nove radici d'esto legno vi giuro che già mai non ruppi fede al mio segnor, che fu d'onor sì degno. E se di voi alcun nel mondo riede, conforti la memoria mia, che giace ancor del colpo che 'nvidia le diede». Un poco attese, e poi «Da ch'el si tace», disse 'l poeta a me, «non perder l'ora; ma parla, e chiedi a lui, se più ti piace». Ond' ïo a lui: «Domandal tu ancora di quel che credi ch'a me satisfaccia; ch'i' non potrei, tanta pietà m'accora». Perciò ricominciò: «Se l'om ti faccia liberamente ciò che 'l tuo dir priega, spirito incarcerato, ancor ti piaccia di dirne come l'anima si lega in questi nocchi; e dinne, se tu puoi, s'alcuna mai di tai membra si spiega». Allor soffiò il tronco forte, e poi si convertì quel vento in cotal voce: «Brievemente sarà risposto a voi. Quando si parte l'anima feroce dal corpo ond' ella stessa s'è disvelta, Minòs la manda a la settima foce. Cade in la selva, e non l'è parte scelta; ma là dove fortuna la balestra, quivi germoglia come gran di spelta. Surge in vermena e in pianta silvestra: l'Arpie, pascendo poi de le sue foglie, fanno dolore, e al dolor fenestra. Come l'altre verrem per nostre spoglie, ma non però ch'alcuna sen rivesta, ché non è giusto aver ciò ch'om si toglie. Qui le strascineremo, e per la mesta selva saranno i nostri corpi appesi, ciascuno al prun de l'ombra sua molesta». Noi eravamo ancora al tronco attesi, credendo ch'altro ne volesse dire, quando noi fummo d'un romor sorpresi, similemente a colui che venire sente 'l porco e la caccia a la sua posta, ch'ode le bestie, e le frasche stormire. Ed ecco due da la sinistra costa, nudi e graffiati, fuggendo sì forte, che de la selva rompieno ogne rosta. Quel dinanzi: «Or accorri, accorri, morte!». E l'altro, cui pareva tardar troppo, gridava: «Lano, sì non furo accorte le gambe tue a le giostre dal Toppo!».